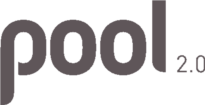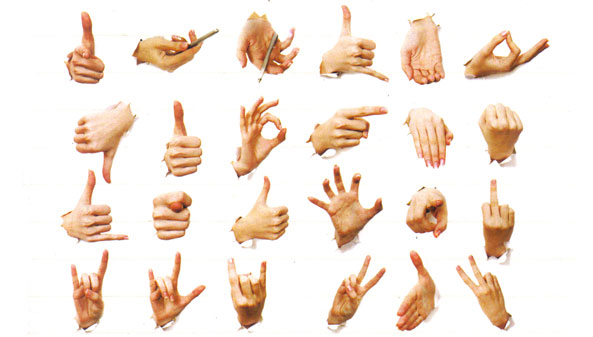REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI BARI
N° 31 DEL 11/08/2009
DIRETTORE RESPONSABILE MICHELE CASELLA
COPYRIGHT POOL ASS.NE DI PROMOZIONE CULTURALE - C.F. 91088660724

L'AUTORE DI L'UNICO SCRITTORE BUONO È QUELLO MORTO RACCONTA IL LAVORO DELL'EDITOR CON DISSACRANTE IRONIA
L’unico Scrittore Buono È Quello Morto, questo il paradossale titolo del libro di Marco Rossari, pubblicato con e/o: paradossale perché l’autore è traduttore e scrittore, a sua volta, e con grande ironia e dissacrazione ha raccolto una serie di spunti e riflessioni sul mondo dell’editoria: potete leggere la recensione al libro sull’ultimo numero cartaceo di Pool, mentre di seguito trovate le sue risposte all’intervista.
Quanta dell’esasperazione dei tuoi personaggi per il mondo editoriale è vera? (Non per fare autobiografismo, ma il tuo libro non è pura fiction, ed essendo tu un ‘addetto ai lavori’ in campo editoriale la domanda s’impone).
Invece è pura fiction. Non c’è nemmeno una riga che riporti un fatto realmente accaduto, ammesso e non concesso che qualcosa di scritto possa riprodurre fedelmente un fatto. Diciamo che il libro prende dei momenti di esasperazione e li porta all’estremo. La realtà editoriale è molto più noiosa: si scrive, si traduce, ci si lamenta. Di solito da soli (e nel terzo caso non è un buon segno). Nel libro, invece di parlare male di questo o quello, ho preferito creare delle situazioni paradossali che raccontano un vuoto, un’idea, una frustrazione tragicomica.
Leggendo «C’era uno scrittore che considerava la letteratura finita, anche perché non leggeva mai un libro» ho pensato al dibattito fra Baricco e Moresco sulla morte della letteratura, sicché questa non è una vera domanda ma l’attesa di una risposta polemica.
Ho letto quello scambio di lettere. In realtà è vero che quando elabora una teoria della letteratura ogni scrittore in fondo in fondo parla della propria poetica. Semplificando un po’, l’idea di Antonio Moresco è quella del tumulto, l’idea di Alessandro Baricco è quella del meccanismo impeccabile. Dentro la frase del mio libro che citi, è nascosta la mia diffidenza – non distante da quella di Moresco – per le sentenze sulla morte di questa o quella forma d’arte. Qualsiasi lettore appassionato sa che la letteratura sopravvive proprio nel suo amore per l’arte. Se il critico è sazio, sono fatti suoi: che si metta una piuma d’oca in bocca e ricominci a leggere… Pensa alla scrittura: doveva morire con la radio, con il cinema, con la televisione e ora con la rete. Eppure mail, sms e social network ci raccontano l’opposto, fatta eccezione per i tweet di Simona Ventura.
Credi che il lavoro degli editor stia causando disastri, nell’editoria contemporanea? Nel tuo libro suggerisci che oggi Joyce sarebbe morto inedito e che a Dante sarebbero stati posti molti vincoli sulla Commedia.
Il racconto su Joyce parla anche di un’altra cosa, ossia di quegli scrittori che alzano sempre di un poco l’asticella della propria ambizione. È un impulso importante. In Ci Hai Provato, James faccio nascere questa sfida dai continui rifiuti, mentre Joyce ha avuto la forza di farlo riuscendo a pubblicare, pur tra mille traversie. Mentre quella di Dante è una facezia nata per caso. Molti anni fa un insegnante mi chiese di scrivere un’ipotetica lettera di rifiuto editoriale e io feci quella per la Commedia, inventando un editor sciocco che in tutti i pregi vede difetti. Ovvio, non sempre è così. Ci sono editor che fanno un buon lavoro e quelli che ne fanno uno pessimo. Di sicuro a volte l’editoria italiana tende ad appiattirsi su certi successi: quanti alchimisti, foglie di limone, albe dovremo vedere? Quanti “libri neri di”? Quante “versione di”? Quanti titoli ripetuti, quante parole ricalcate, how many roads must a man ecc.? Si dice che un vocabolo raro possa dare un impulso sano al cervello: bene, ricordiamocelo. Non atrofizziamo il lettore, altrimenti non verrà più attratto da ciò che è diverso, ma solo da ciò che banale. A quel punto anche pubblicare un capolavoro servirà a poco se la scuola e la famiglia non hanno formato un lettore pronto a recepirlo; resterà in un angolo della libreria, seppellito da libri sciocchi.
L’episodio di Tolstoj intervistato in radio ai nostri giorni fa riflettere sulla superficialità della critica letteraria: credi che molti si improvvisino recensori o esperti in campo letterario? Come distinguere la qualità di libri e critici?
L’episodio di Tolstoj è anche una riflessione sul rapporto con il lettore. A volte aiuta, altre ancora no. Ogni persona ha idiosincrasie, manie, tic, grandi odi e amori (io per primo). Oggi l’autore è messo davanti a una grande quantità di pareri, ad esempio sui social network, e questi rischiano di disorientarlo. O di bloccarlo. “Una volta uscito, il libro non è più tuo” si dice spesso. Certo, ma se vai dietro a ogni opinione finisci per smarrire il senso del tuo lavoro, come il buon Tolstoj che viene inghiottito nella tormenta. Per quanto riguarda l’improvvisazione, si trovano delle brutte recensioni sia in rete che sui giornali. Molti “professionisti” danno un’occhiata al libro e buttano giù il pezzo in automatico, mentre diversi internauti “dilettanti” scrivono splendide critiche. A volte la passione svincolata dal lavoro, e quindi dalla retribuzione, è più sincera e regala molte più soddisfazioni. Altre volte dire la propria opinione sembra diventato un dovere. Pensa: lo sto facendo anch’io.
A cura di Carlotta Susca